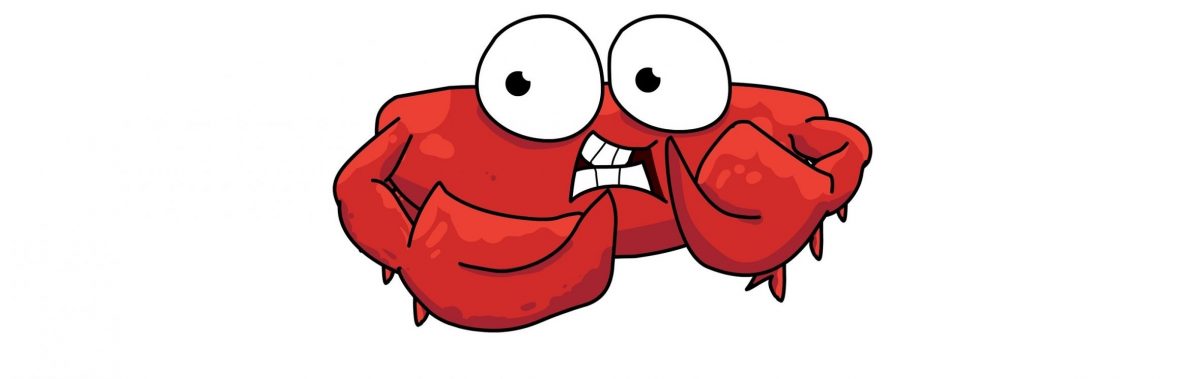Scena Prima
Sono proprio un gran figo.
Nessun cervo può competere con me in quanto a bellezza, nemmeno quell’altro maschio che mi ha caricato quando mi sono avvicinato al gruppo delle femmine. Quello è orribile con quei palchi sul testone; sarà pure il capobranco, ma è meglio essere soli come me che cornuti come lui.
Trotterello tra i nidi di ferro, risalgo fin sotto la stella gigante, mi fermo davanti a una pozza. L’acqua ferma riflette la mia testolina a forma di pigna, le spalle arrotondate e il petto largo. Che eleganza, sono un figo pazzesco. E gli uomini buoni lo sanno, per questo motivo mi porgono erbetta fresca e ramoscelli con tenere foglioline.
Ci sono anche uomini cattivi con canne rumorose che sputano ghiande mortali. Quelli uccidono cinghiali, alci e altri cervi. Li ho visti bene col mio occhio. Ma quelli stanno nel bosco dove ci sono pure i lupi, e io nel bosco non ci torno perché è troppo pericoloso. Non ci torno, e resto qui tra le tane abbandonate degli uomini.
Sollevo una zampa anteriore e schiaffo lo zoccolo nella pozza. La mia immagine si rompe. Divertente. Sollevo entrambe le zampe anteriori e giù di nuovo nella pozza. L’acqua esplode e schizza dappertutto. Molto divertente.
Scena seconda
Il chiarore dell’alba filtra attraverso le chiome degli alberi. Il paesaggio si accende. I pioppi si scuotono di dosso le gocce fredde della notte, le betulle sfoggiano le eleganti cortecce bianche, una ragnatela disordinata luccica tra le foglie basse di un cespuglio.
Oreste controlla la mappa e rimette il cellulare in tasca.
Mi ci avvicino e gli bisbiglio in un orecchio: «Ci siamo persi di nuovo?»
«Rino, non mi stressare» sussurra lui. «Siamo quasi arrivati.»
Sospiro.
«Io continuo a sostenere che sarebbe stato meglio se ci fossimo fatti accompagnare dal tuo amico stalker.»
«Ma chi, Ivan?»
«Sì, quello con cui sei venuto qui nella zona di esclusione l’anno scorso e pure l’anno prima.»
«Ivan è pazzo.» Si gratta la parte della coscia che si è ferito passando sotto il filo spinato. «Meglio non avere niente a che fare con tipi come lui.»
«Però ti ha fatto tornare a casa sano e salvo entrambe le volte.»
«Sì, ma quel pazzo mi ha chiesto un sacco di soldi.» Strizza un occhio. «Fidati di me, ormai anch’io sono uno stalker, e ti sto pure facendo risparmiare.»
«In questo momento darei a quel pazzo un milione di euro per farmi dire dove ci troviamo.»
«Tu non hai un milione di euro perché sei un fatto-rino col moto-rino che mi porta lo scont-rino e la pizza col rosma-rino.»
Mi lascio scappare una risata. Quattro giorni e mezzo di cammino senza un pasto decente, con gli scarponi che sembrano macigni, con la pioggia che si è presentata puntuale ogni giorno, dormendo pochissimo in ruderi gelidi, con la puzza degli escrementi dei topi nelle narici, e mio cugino riesce ancora a farmi ridere.
«Ridi in silenzio, per favore, che siamo arrivati.» Fa la sua smorfia buffa con le guance, corruga la fronte, e indica una palazzina fatiscente caduta tra le grinfie di una macchia di pini. «Te l’ho detto che Oreste conosce bene queste f-oreste.»
Soffoco la seconda risata con le mani.
Il rapido tambureggiare come di qualcuno che bussa con la punta di una chiave su una porta di legno infrange il silenzio.
Oreste si lancia alla sua destra tra l’erba alta. Lo imito e mi tuffo tra i rovi alla mia sinistra. Le spine si aggrappano ai vestiti imbottiti.
Il tambureggiare si ripete. Silenzio. Si ripete di nuovo.
«Rino» bisbiglia la voce di Oreste. «Rino, vieni fuori. Falso allarme.»
Mi rimetto in piedi e lo raggiungo.
«Chi è che fa questo rumore?»
Oreste indirizza lo sguardo verso la cima di un albero.
«Ecco il colpevole.»
Un picchio sferra una serie di beccate sul tronco.
Oreste punta l’indice contro l’uccello.
«Se mi fai spaventare ancora, ti picchio.»
Ci rimettiamo in marcia. Zigzaghiamo tra gli alberi.
«Salici» mormora Oreste.
«Non ci salgo» sussurro.
«E dai, su, salici.»
«Salici tu.»
«Salici loro.»
Ridiamo entrambi. Questo scambio di battute durante le nostre passeggiate è ormai una consuetudine che va avanti da anni. Eravamo studenti di scuola elementare la prima volta che abbiamo inscenato questo stupido spettacolino in campagna dei miei zii in Sicilia, e adesso che siamo universitari, ricordiamo quegli istanti ogni volta che vediamo un salice. Ma chi lo avrebbe mai detto che saremmo tornati bambini con la mente a due passi dalla centrale nucleare di Chernobyl?
Sbuchiamo su una stradina asfaltata che l’erba sta cercando di conquistare. Proseguiamo diritto. Le case e gli edifici tutt’attorno sono soffocati nel verde.
«Siamo arrivati.» Oreste tira fuori il contatore Geiger. «Ti presento il parco divertimenti di Pripyat.»
Mi fermo accanto all’autoscontro con le automobiline corrose. La vista delle giostre devastate mi blocca in gola ogni parola, il pensiero che nessun bambino abbia mai potuto giocare in questo luogo mi torchia il cuore. Tolgo lo zaino dalle spalle, lo poggio sull’asfalto bagnato e tiro fuori una bottiglia piena. Bevo solo un sorso; meglio risparmiare l’acqua per il ritorno.
Il contatore Geiger ticchetta e trilla; da quando siamo partiti non aveva trillato così forte. Il male invisibile ci circonda.
Oreste zittisce il ticchettio, ripone lo strumento in una tasca laterale dello zaino e riprende il cellulare.
«Andiamoci a fare un selfie con Cervobyl.»
«Come fai a essere sicuro di trovarlo proprio qui?»
«Perché è in quest’area che gli stalker gli portano da mangiare.»
«Non potrebbe essere morto nel frattempo?»
«Non credo.» Indica un punto oltre l’immobile ruota panoramica. «Eccolo là.»
Un quadrupede dal manto brunastro saltella in una pozzanghera.
Seguo i passi lenti di mio cugino. Ci avviciniamo al famoso cervo con la testa a forma di limone che da lontano sembra non avere affatto una testa. Il maestoso cerchio di metallo svetta su di noi coi suoi tristi seggiolini gialli.
Oreste si sfila lo zaino, ci rovista dentro e tira fuori il biberon.
«Cervobyl, bello, vieni qui bello.»
L’animale ci fissa con l’unico occhio che gli dona le sembianze di un fantastico ciclope-centauro. Apre la minuscola bocca ed emette un sibilo gutturale.
Oreste agita in aria la tettarella. «Zitto bello, dai, vieni qui» mormora.
Cervobyl solleva il naso appuntito e gli va incontro. Annusa il capezzolo gommoso e si mette a poppare l’acqua del contenitore.
«Bravo bello, bevi tutto.» Oreste mi fa un cenno con la mano libera. «Rino, non stare lì impalato. Riprendi tutto.»
Prendo il cellulare e avvio la registrazione di un video. «Davvero sorprendente» sussurro. «Non ha per nulla paura delle persone.»
«In realtà si nasconde quando sente schiamazzi e scappa ogni volta che vede masse di visitatori.» Oreste accarezza la testolina nel punto in cui dovrebbero esserci corna e orecchie. «Gli stalker gli si avvicinano singolarmente, al massimo in coppia, e non gli parlano mai ad alta voce.»
«E perché non vogliono che gli si facciano foto o video?»
«Cercano di proteggerlo.» Oreste sfila la tettarella dalla boccuccia e ripone il contenitore vuoto nello zaino. «Sarebbe morto senza il loro aiuto, perché da solo non riesce a mangiare e bere adeguatamente.»
Concludo la registrazione e salvo il video.
«E se gli stalker ci scoprissero?»
«Saremo già in Italia quando ci scopriranno, sarà troppo tardi ormai.» Oreste ridacchia dal naso. «Avremo milioni di visualizzazioni grazie a questo mostriciattolo, diventeremo famosi.»
Cervobyl ci scruta a turno.
Oreste strappa un pugno di erba così bassa che l’animale non riuscirebbe a brucarla neppure da sdraiato, con l’altra mano tira fuori il cellulare.
«Vieni qui che ci facciamo un bel selfie col nostro amico prima di svignarcela.»
Cervobyl apprezza lo spuntino e si lascia scattare un paio di foto con le nostre facce a un palmo dalla sua.
Una voce estranea rimbomba nello spiazzo.
Mi volto, col cuore impazzito, cerco lo sguardo di mio cugino.
«Stanno arrivando gli stalker?»
Cervobyl se la svigna tra gli alberi.
«No, sono i militari.» Oreste indica due uomini in divisa mimetica e cappellino blu che in lontananza ci vengono incontro dalla strada opposta rispetto a quella dalla quale siamo arrivati. Aggancia il cellulare al bastone per i selfie e si rimette lo zaino in spalla.
«E che facciamo adesso?» La mia voce trema. «Che cosa stai combinando?»
«Gli faccio un video mentre ci inseguono.» Mi ammicca con un’espressione seria che poco si adatta al suo modo di essere. «Corri accanto a me, recupera al volo il tuo zaino e non fermarti per nessuna ragione al mondo.»
I soldati urlano parole incomprensibili.
Oreste lancia un’occhiata ai due in avvicinamento e allunga al massimo l’asta telescopica.
Uno scoppio sovrasta ogni voce, ogni suono.
Mi tappo le orecchie, mi chino.
Mio cugino stramazza al suolo a faccia in giù.
«Oreste» strillo. «Alzati Oreste!»
Mi cugino non si muove. Lo strattono. Ha un buco sulla tempia, un foro di proiettile dal quale fuoriesce un rivolo di sangue.
I due assassini continuano a sgolarsi, nell’aria contaminata, nella loro lingua russa, ucraina o quel che diavolo è. Entrambi imbracciano un fucile.
Mi rialzo e scappo. Mi precipito verso l’autoscontro, afferro il pesante zaino e lo abbandono lì dov’è come ho fatto col corpo del povero Oreste. Scatto sull’asfalto e mi catapulto tra la vegetazione. Sfreccio tra ruderi che non c’erano all’andata, attraverso stradine sconosciute. La nausea e le lacrime non arresteranno la mia corsa.
Scena terza
Antonov mi strattona per una manica dell’uniforme.
«Che succede?»
Si porta l’indice sul naso e sulla bocca. «Intrusi» mormora.
Il dito si sposta in direzione del parco divertimenti, indica due uomini fermi sotto la ruota panoramica.
Annuisco e impugno il fucile. La canna in diagonale, puntata verso il suolo.
Avanziamo affiancati, i nostri stivali pestano l’asfalto all’unisono.
«Non muovetevi!» urla Antonov.
I due uomini ci vedono. Un cervo corre tra gli alberi alla loro sinistra.
«Alzate le mani e non muovetevi!»
L’intruso vestito di nero traffica con un oggetto e si mette uno zaino sulle spalle. Gli puntiamo addosso i fucili con gli indici pronti sui grilletti.
«Mettete le mani bene in vista e restate fermi» tuona Antonov.
L’intruso vestito di nero ci rivolge contro qualcosa che somiglia a un’arma. Parte un colpo. L’intruso vestito di nero crolla a terra.
Antonov mi guarda con gli occhi strabuzzati.
Le mie mani tremano. Dannazione, sono stato io a sparare. Maledizione, no, perché? Antonov corre. Corro anch’io. L’intruso vestito di marrone si china, tocca l’altro, si rialza e scappa via.
Antonov gira il ferito a faccia in su, gli palpa il collo.
«Zelenko, ma che ti passa per la testa? Lo hai ammazzato!»
Accanto al ragazzo c’è un selfie stick collegato a uno smartphone. Rabbrividisco, mi si annebbia la vista, le mani sudano, il viso avvampa. Un’ora fa salutavo con un bacio la mia bella Bogdana, accarezzavo nella culla le guance vellutate della mia piccola Eva, e adesso ho appena ucciso un uomo disarmato.
Antonov sgancia dalla cintura la ricetrasmittente. «Zelenko, muoviti» mi urla addosso. «Corri ad acciuffare quell’altro mentre io avviso la base sull’accaduto.»
Un groppo mi stringe la gola.
«Che succederà adesso?»
«Non ti preoccupare, Zelenko, risolveremo questa situazione.» Mi dà una manata sul petto. «Ora però devi andare a prendere quell’altro.»
Chino il capo e parto all’inseguimento.
Scena quarta
Paura. Galoppo. Paura.
Sono proprio veloce, nessun uomo può competere con me in quanto a velocità, sono velocissimo. Ora però rallento tra questi alberi e queste tane abbandonate perché mi sono allontanato a sufficienza dal pericolo.
Gli uomini cattivi con le canne rumorose hanno invaso anche il posto con la stella gigante. Non è più sicuro andare lì. L’acqua e l’erbetta tenera degli uomini buoni mi piacciono, ma gli uomini cattivi rovinano sempre tutto con le loro ghiande mortali.
Meglio restare qui finché non torna la notte. Meglio restare nascosto, perché di giorno arrivano gli altri uomini, quelli che fanno confusione. Chissà se gli uomini buoni mi porteranno da mangiare anche qui, chissà se mi daranno ancora da bere.
Mi fermo davanti alle betulle, annuso i tronchi. Ora sai che faccio? Rosicchio le cortecce come quando c’è la neve. Sì, faccio finta che c’è la neve. Faccio finta che c’è la neve e rosicchio le cortecce delle betulle.
Passa la paura. Pericolo scampato.
☢️
Nota dell’autore: Questo racconto è stato selezionato al concorso letterario “I Racconti di Cultora” e pubblicato nel Volume I dell’antologia “I Racconti di Cultora 2019”, edita da Historica Edizioni.